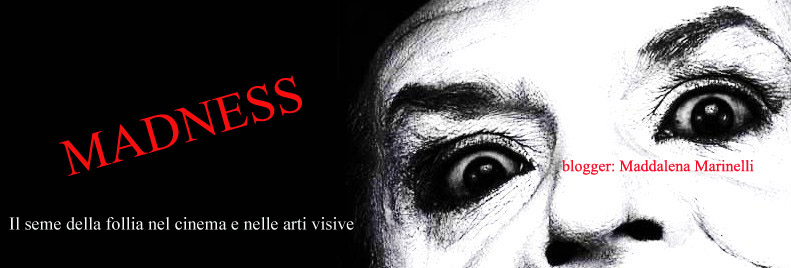Quell’insano lirismo
della carne
Di Maddalena Marinelli
Il
mondo di Witkin è come quello spazio interstiziale sporco e dimenticato
nascosto tra normali pareti domestiche.
Tutto
inizia da una bella e linda carta da parati leggermente scollata; poi si scopre
una fessura, lo spiraglio diventa sempre più grande ed ecco ‘l’altra stanza’
col suo odore marcente che ti penetra nelle narici, con i suoi perversi segreti
e le sue terrorizzanti storie inascoltate. L’irruzione del diverso.
“La fotografia è una
mannaia che coglie nell'eternità l'istante che l'ha abbagliata.”
(Henri
Cartier-Bresson, Il momento decisivo, 1952)
Un
effluvio di morte, di carne e di fiori avvizziti. Una lama affilata che taglia
e rincolla i pezzi ricreando nuove narrazioni secondo lo stato d’animo del
sogno.
Sessualità
e violenza si uniscono.
Carrucole,
corde, cinghie, pungoli, fruste, lattice, bende, maschere per attività
parafiliache mostrate nel loro compiersi da persone che
provano normalmente piacere infilandosi aghi nello scroto e ganci nei
capezzoli.
Non
sono futuri tormenti infernali ma supplizi quotidiani.
Gli
inquietanti abitatori di queste stanze nascoste sono gli esemplari di una nuova
bellezza. I protagonisti di un perverso burlesque portato all’estremo.
Nelle
mani dell’artista il deforme diventa armonico e il nostro sguardo bulimico, tra
attrazione e repulsione, non può far altro che nutrirsi avidamente di tali
immagini per poi rigettarle chiedendo a noi stessi l’origine di questa morbosa
seduzione visiva.
La
forma mentis di Joel Peter Witkin inizia
con un macabro episodio legato all’ infanzia. Da bambino fu testimone di un
tragico incidente d’auto avvenuto davanti alla sua abitazione in cui rimase
decapitata una bambina. Quella testa recisa ritornerà spesso nel suo
immaginario visivo.
Vede
le fotografie della Grande Depressione, quelle dei campi di concentramento
pubblicate su Life, quelle di Eugene Smith al ritorno dal Giappone
post-atomico. All’inzio della sua carriera accetta di partire per il Vietnam
come fotografo di guerra trovandosi a documentare i suicidi e le morti
accidentali in servizio.
E’
il dramma, il sangue, la ferocia del Novecento che s’imprimono nei suoi occhi
per riversarsi in creazione artistica.
La
sua ricerca si concentra sul tema della morte, sull’anomalia fisica per poi
arrivare alle rivisitazioni irriverenti di famose opere di Goya, Velazquez,
Picasso, Max Ernst, Bosch, Caravaggio,
Botticelli, Salvador Dalì, Beato Angelico, Rembrandt, ribaltandone
l’intera iconologia con l’aggiunta di riferimenti all’attualità sociale e
politica.
Molto tempo è impiegato per l’elaborazione dell’idea, la composizione spaziale e lo studio dei riferimenti simbolici. I suoi set durano mesi, iniziano da disegni preparatori per poi passare alla costruzione tridimensionale fino allo scatto vero e proprio.
Molto tempo è impiegato per l’elaborazione dell’idea, la composizione spaziale e lo studio dei riferimenti simbolici. I suoi set durano mesi, iniziano da disegni preparatori per poi passare alla costruzione tridimensionale fino allo scatto vero e proprio.
Sono
creazioni scenografiche studiate nei minimi dettagli, tableaux vivants con
richiami mitologici, teatrini della crudeltà sadomaso. I suoi modelli, fuori
dalla norma, vengono ingaggiati in incontri fortuiti o tramite inserzioni.
Carne
ferita e torturata. Tutto passa attraverso la sofferenza. Un continuo martirio
del corpo per trovare uno stato d’estasi seguendo proprie leggi.
Il
lavoro procede in camera oscura dove Witkin da fotografo diventa un pittore
informale. Interviene manualmente con graffi, colore, lacerazioni, bruciature,
candeggina, prodotti chimici, collage, distorsioni tra il supporto e
l’ingranditore.
Le
sue celebri Still lifes con membra
umane, corpi mutilati magnificati come statue classiche, ermafroditi come
veneri in Gods of Earth and Heaven
(1988), obesi, nani, gigantesse.
In
questo inno all’ Elephant Man c’è ironia ma anche una continua insistenza sulla
caducità e la fragilità del corpo umano.
Woman once a Bird del
1990, richiamo all’opera Le violon
d’Ingres (1924) di Man Ray a sua volta caustica citazione dell’opera La bagnante di Valpinçon (1808) di
Ingres. Tre concezioni molto diverse dell’arte nell’evolversi dei tempi. La
versione di Witkin è quella di un corpo femminile seduto di spalle stretto in
vita da un inconcepibile bustino di metallo. Una punizione.
Sulla
schiena due profonde lacerazioni come traccia rimasta di ali strappate via.
Ogni
artista è alla ricerca di quelle ali
perdute per riuscire a riconsegnarle all’uomo.
Un’ossessione
per la morte e il decadimento che la nostra società rifiuta propinandoci elisir
di lunga vita, corpi perfetti, interventi chirurgici che rimpolpano carni flaccide.
Invece Witkin vuole rapportare lo spettatore con quell’aspetto più terrifico e
sacrilego in cui riecheggia assordante l’ammonimento del memento mori.
Utilizza
cadaveri non reclamati presi negli obitori messicani, li scompone e ricompone
nel suo studio in sfarzose nature morte. Nobilitazione o nefandezza?
Teste
decollate poggiate su piatti, braccia e gambe amputate assemblate con fiori e
oggetti secondo precise composizioni. Feti, organi sessuali, ossa, corpi
ricuciti.
Una
variazione, anzi meglio, una sovversione delle fotografie post mortem che si diffusero
in epoca vittoriana per avere un ricordo del defunto in cui l’usanza più inquietante
era posizionare il cadavere come se fosse ancora vivo, con gli occhi aperti e simulando
qualche attività quotidiana.
Così
si prova ad ingannare la morte strappando, anche all’ormai defunto, quell’ultima
immagine di vita eternamente sospesa.