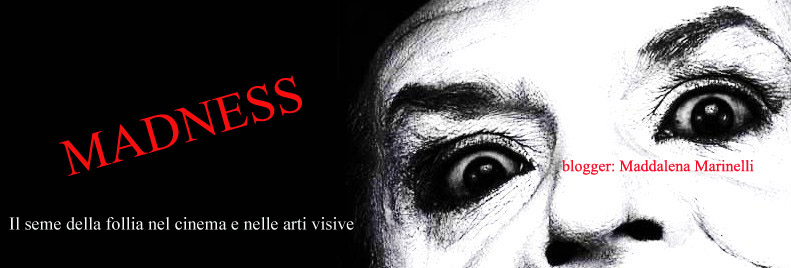|
| 'GOLTZIUS AND THE PELICAN COMPANY' (2012) di Peter Greenaway - visibile su CHILI |
Il volto impuro
dell’arte
di Maddalena Marinelli
L’arte, il potere e l’artista.
L’arte, per sua natura e funzione, contrasta il potere
evidenziandone tutti i limiti, le ipocrisie, i soprusi, la violenza ma allo
stesso tempo l’artista non può rimanere fuori dall’ingranaggio e dagli
interessi economici.
Ecco consumarsi un gioco senza fine tra lo scendere a compromessi e il ribellarsi mettendo in moto una serie di conseguenze.
“L’opera d’arte è sempre una confessione” (Umberto Eco)
Ecco consumarsi un gioco senza fine tra lo scendere a compromessi e il ribellarsi mettendo in moto una serie di conseguenze.
“L’opera d’arte è sempre una confessione” (Umberto Eco)
Oppure è soltanto
una consolazione come diceva Thomas Mann?
Peter Greenaway in Goltzius and the Pelican Company riflette, con la sua cinica ironia, su questa tematica andando ad incastrarne molte altre all’interno di un’ideale ‘opera totale’.
Una scatola magica in cui avviene la teatralizzazione dell’arte e della vita.
Anzi molto di più, un contenitore ipertestuale che ha la pretesa di raccontare una vicenda integrandola con visioni rielaborate che provengono dalla storia dell’arte, dell’architettura , del teatro.
Peter Greenaway in Goltzius and the Pelican Company riflette, con la sua cinica ironia, su questa tematica andando ad incastrarne molte altre all’interno di un’ideale ‘opera totale’.
Una scatola magica in cui avviene la teatralizzazione dell’arte e della vita.
Anzi molto di più, un contenitore ipertestuale che ha la pretesa di raccontare una vicenda integrandola con visioni rielaborate che provengono dalla storia dell’arte, dell’architettura , del teatro.
Un’
opera filmica che diventa una vera e propria lezione sul sapere umano in cui la
complessità dell’immagine è sempre pari a quella data all’oralità e alla
scrittura.
Una delle più famose provocazioni del regista gallese è asserire la morte del cinema. Infatti Greenaway sottomette completamente la tecnica cinematografica ai misteri della creazione artistica, per lui esiste solo l’immensità dell’arte.
Una delle più famose provocazioni del regista gallese è asserire la morte del cinema. Infatti Greenaway sottomette completamente la tecnica cinematografica ai misteri della creazione artistica, per lui esiste solo l’immensità dell’arte.
Continua ad essere un pittore, compositore d’immagini, passando dalla tela allo
schermo trascinandosi dietro il suo debordante taccuino di appunti, teorie, immagini,
pensieri, parole, musiche.
 |
| 'GOLTZIUS AND THE PELICAN COMPANY', di Peter Greenaway |
Gli unici personaggi a cui è interessato sono gli artisti: l’architetto, il pittore, lo scrittore sempre usati come chiave per entrare in un territorio immaginifico riccamente stratificato e dare vita al suo esclusivo organismo: un’opera/saggio multidisciplinare.
Il suo più grande amore è senza dubbio la pittura soprattutto quella del Rinascimento, Manierismo e Barocco.
La
teatralizzazione gli ha permesso di far esplodere tutta la magnificenza, i simbolismi, la ricchezza
cromatica di questi periodi storici così fecondi per la produzione artistica.
L’olandese Hendrik Goltzius è stato uno dei grandi incisori olandesi del primo periodo Barocco, ovvero del Manierismo settentrionale.
L’olandese Hendrik Goltzius è stato uno dei grandi incisori olandesi del primo periodo Barocco, ovvero del Manierismo settentrionale.
Famoso per le
sue stampe erotiche. Il film racconta le peripezie dell’artista Goltzius e
della sua compagnia teatrale alla corte del Margravio d'Alsazia.
Per convincere
quest’ultimo a finanziare un libro di preziose stampe, sulle storie del Vecchio
Testamento, i teatranti accettano di interpretare ogni sera, per il piacere del
Mangravio, alcune delle più emblematiche e controverse vicende delle sacre
scritture: Adamo ed Eva e il peccato originale, Lot e le sue figlie, Giuseppe e
la moglie di Putifarre, Davide e Betsabea, Sansone e Dalida, Salomé e Giovanni
Battista.
L’attenzione si concentra su 'sei tabù' legati alla sfera del sesso
(fornicazione, incesto, adulterio, seduzione
dell’innocente, prostituzione e necrofilia) rappresentati attraverso autentiche
performance sessuali dal vivo.
Raffinati tableaux vivants pornografici in cambio di finanziamenti per l’attività
della stamperia artistica.
Viene liberata tutta quella carica violenta nascosta nei
testi sacri.
Presto l’atmosfera festosa inizierà a tingersi del sangue di evirazioni, flagellazioni e decollazioni come se ad ogni amplesso susseguisse un’inevitabile azione punitiva in una crescente atmosfera sadica alla Sodoma e Gomorra.
Presto l’atmosfera festosa inizierà a tingersi del sangue di evirazioni, flagellazioni e decollazioni come se ad ogni amplesso susseguisse un’inevitabile azione punitiva in una crescente atmosfera sadica alla Sodoma e Gomorra.
Tutto questo sotto
gli occhi di Goltzius che sdoppiandosi è simultaneamente dentro gli accadimenti
e fuori, come volto e voce narrante.
In entrambi i casi impotente di fronte alle
tante sofferenze patite dai suoi amici.
L’artista potrà solo osservare
l’implacabile decorso e proseguire da superstite la sua missione artistica.
Condividere
le sue erudite deduzioni sulle
disavventure della Compagnia del Pellicano, trasponendo le emozioni in immagini
e parole.
 |
| 'GOLTZIUS AND THE PELICAN COMPANY', di Peter Greenaway |
La meravigliosa ascesa dell’arte e la sua discesa, il retroscena più crudele.
Sesso e morte sono le tematiche preferite da Greenaway ma in Goltzius and the Pelican Company c’è anche l’ossessione per la conoscenza, le controversie sulla morale sessuofobica del Cristianesimo, l’ottusità del potere politico messo in ridicolo, il potere temporale della Chiesa che addirittura alla fine si rivela come il primo grande stratega ricollocando ogni cosa secondo un infido ordine.
L’analisi
del regista gallese è molto dura nei confronti del ruolo dell’artista nella
società. Un altro tema centrale è quello della mercificazione dell’arte e
dell’erotismo.
Vuole mostrare il torbido che si nasconde dietro lo splendore
artistico ed evidenziare quelle scelte meno edificanti a cui è sottoposta la carriera dell’artista.
Davvero
un perverso ossimoro.
Costruire visivamente la più spettacolare esaltazione
dell’arte e poi calargli addosso una cappa nera.
Non ci viene dato il tempo di contemplare le immagini perché veniamo assaliti dall’incessante flusso delle parole intinte in una pungente satira.
La sceneggiatura si divide in tre piani narrativi.
Non ci viene dato il tempo di contemplare le immagini perché veniamo assaliti dall’incessante flusso delle parole intinte in una pungente satira.
La sceneggiatura si divide in tre piani narrativi.
C’è ‘la trama biblica’ che
risalta la rappresentazione delle sei
storie tratte dal Vecchio Testamento.
La seconda è ‘la trama del Margravio’ che
evidenzia le conseguenze delle rappresentazioni dei racconti biblici sulla
corte e sugli attori.
La terza è ‘la trama di Susanna e i vecchioni’ - il voyerismo che passa dall’artista al
Margravio fino al pubblico in sala - che spiega l’ossessione di Goltzius per
l’erotismo, le ragioni personali del suo comportamento equivoco
e il cambio del suo orientamento sessuale.
Il fulcro visivo,
in primo piano, che cattura l’occhio è maestoso come un altare sacro.
Un Cinquecento ricostruito all’interno di un fabbricato industriale in disuso.
Un Cinquecento ricostruito all’interno di un fabbricato industriale in disuso.
Il regale scenario è illuminato da una luce
raggelante proiettata su corpi che già
sembrano lattescenti cadaveri preannunciando il loro imminente sacrificio
all’interno dell’enorme palcoscenico di delizie e supplizi in cui pubblico e
attori vengono (p)uniti. Tutti entrano ed escono dalla finzione alla realtà.
Quindi
tutti possono trovarsi sotto inquisizione anche lo spietato Margravio.
La composizione visiva è sempre molto complessa.
La composizione visiva è sempre molto complessa.
La scena, ispirata ad opere
pittoriche, racchiude una ricercata
iconografia.
Tutto ciò viene custodito, a sua volta, all’interno di un impianto
architettonico che scandisce lo spazio e lo trasforma apparendo improvvisamente
sottoforma di modellazioni in 3D.
Al
centro c’è il corpo dell’attore come cuore pulsante e recitante, mai semplice
apparizione.
L’attore è chiamato a dimostrare di essere tale e la sua oralità deve
emergere insieme all’impianto visivo che
abita.
Ogni elemento è una chiave che apre altre porte da attraversare in un mondo che ci trascina dentro il suo lento declino in cui si riflette lo sfacelo della società contemporanea.
Ogni elemento è una chiave che apre altre porte da attraversare in un mondo che ci trascina dentro il suo lento declino in cui si riflette lo sfacelo della società contemporanea.
L’estremismo di Greenaway adora distruggere almeno
quanto ama creare.